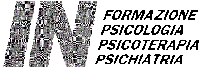
La definizione della domanda adolescenziale
ovvero Note sull'Ombra del "genitore cattivo"
(pubblicato in: Informazione in psicologia, psicoterapia, psichiatria, n. 26, Roma, 1996, pp.20-23)
Maria Giovanna Mazzone*
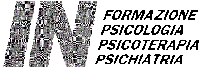
Il confronto con alcuni colleghi, nell'ambito di un gruppo clinico sugli adolescenti, mi ha indotto a riflettere sull'opportunità di aiutare questi pazienti a definire in modo chiaro e condiviso la propria domanda terapeutica. Mi sono chiesta se - a volte - il rispetto della condizione specifica dell'adolescente, in sospeso tra necessità regressive e istanze evolutive, non corra il pericolo di sfumare in una collusione con questi suoi particolari aspetti, favorendo il ristagno in uno status quo che può impedire o ritardare l'evoluzione.
Il presupposto di questo atteggiamento terapeutico potrebbe essere un aspetto d'Ombra di quell'analista che, confondendo la rigidità con la fermezza, si preoccupi di non apparire prescrittivo e intransigente come può essere un genitore.
Il caso di Marina - una diciottenne anoressica - mi ha confermato in questo mio orientamento. Appena arrivata nel mio studio, la ragazza mi sedeva davanti seria e composta, col busto eretto e lo sguardo fermo. Sembrava portare con baldanza i tratti di una bellezza esotica verosimilmente dovuta alla madre africana, ma nascondeva i foltissimi e lunghi capelli ricci dentro un baschetto di foggia maschile. Un pesante maxipaletot, che non si tolse per diverse sedute, le sfiorava i tacchi degli stivali da uomo, a coprire qualunque eventuale morbidezza del corpo. Mi parlava della famiglia e della scuola senza tradire nessuna emozione e con la massima proprietà di linguaggio, ma - mentre all'inizio raccontava le cose come se appartenessero a qualcun altro - in seguito la sua espressione cambiò: le labbra si ammorbidirono e gli occhi smisero i primitivi lampi di seduttività per rivelare un aspetto di bimba imbronciata e oppositiva. L'idea di incontrarci due volte a settimana le pareva impensabile. Era appena in grado di sostenerne una - diceva - perché era stanca... aveva da studiare... abitava fuori Roma... Era propensa agli incontri quel tanto per non contrariare i suoi e per non tradire del tutto il proprio disagio, ma non abbastanza per assumersi lei il carico della propria sofferenza e della volontà di uscirne.
Da parte mia, ho impiegato sette sedute a stipulare con lei un contratto in cui figurasse come parte attiva e non come una renitente obbligata alla leva. Più volte è stato necessario, in seguito, tornare su questo aspetto e non ho mai nascosto che ritenevo utile che lei ricercasse ed esplicitasse le proprie motivazioni alla terapia. Diluirle in una palude indifferenziata, abitata da un papà ipercontrollante e disertata da una mamma fredda e incongrua, non le sarebbe servito né a cambiare i suoi né ad aiutare se stessa.
Perciò, pur accogliendo questo suo vissuto rispetto ai propri genitori e la sofferenza che gliene derivava, ho incoraggiato Marina a porsi davanti a me come soggetto in grado di esplicitare delle richieste. Finché - dopo diversi mesi di lavoro - la ragazza ha domandato di poter avere la seconda seduta settimanale che avevo fissato per lei fin dall'inizio. Senza forzarla ad accettare (tra l'altro la paziente aveva accessi di bulimia, seguiti da vomito), avevo descritto più volte come "sua dentro di me" - anche se non pagata - quell'ora che effettivamente non avevo mai occupato con altri pazienti e che in seguito Marina ha chiesto di usare.
Durante tutto il tempo necessario a definire i vari livelli della sua domanda, mi è capitato di chiedermi se per caso non stessi cadendo con questa ragazza in un atteggiamento più genitoriale che terapeutico, ma l'esito del lavoro mi ha suggerito che l'assunzione di un eventuale tratto genitoriale nella terapia con adolescenti non sia da temere più di tanto.
Questa mia convinzione cade al di fuori di un'area professionale che considera sconsigliabile una simile posizione, vista come scarsamente adatta ad accogliere la realtà psicologica di un paziente di quell'età. Accettare che la domanda resti sfumata pare l'antitodo al pericolo di pretendere - come spesso fanno i genitori - che il ragazzo cresca presto, si definisca, agisca finalmente un'opzione adulta rispetto al desiderio di rimanere bambino. Certamente è difficile per il terapeuta, cosė come per un padre o una madre, tollerare la nebulosità di un "fieri" portato difensivamente come status ed è bene avere presenti le conseguenze di una fuga verso un obiettivo di crescita certo e desiderabile. Ma c'è da chiedersi se non sollecitare l'esplicitazione di una domanda terapeutica sia un modo corretto di stare con l'ambivalenza adolescenziale. Forse è possibile non rigettarla proprio con il contenerla insieme alla chiarezza dello sforzo evolutivo cui tendere. Altrimenti, viene il dubbio che questo non voler correre il rischio di fare il genitore intollerante peschi - come già detto - nell'ombra dell'analista, che può agirla reattivamente cercando di porsi come permissivo.
Personalmente, pur concordando sulla necessità di accogliere il portato specifico di chi ci sta davanti, trovo che il timore di essere pedagogici piuttosto che terapeutici non debba inibire una funzione che mi sembra fondamentale, invece, in un approccio di tipo junghiano: la definizione di un polo evolutivo che faccia da contraltare alle istanze regressive del paziente, consentendogli il conflitto attraverso cui elaborare la propria personale sintesi individuativa.
All'interno del paziente va considerata una coppia di polarità opposte, nel senso cioè di una coesistenza di immagini, di cui una ancorata al passato di bambino e l'altra orientata al futuro di adulto. Quest'ultima porta a sua volta sia il desiderio di distaccarsi dai genitori, magari in modo appariscente o patologico, sia il desiderio di mantenere con essi un'alleanza utile alla crescita. Credo si possa concordare con quegli autori (Telleschi e Torre - 1988) i quali ritengono che il compito del terapeuta sia di rispettare e tutelare l'alleanza interna che l'adolescente ha formato con i genitori o proporsi lui stesso come alleato quando la patologicità del legame con essi non lo consenta.
E' utile perciò che l'analista si rappresenti il confronto con i genitori non tanto come una relazione interpsichica con il genitore in carne e ossa, quanto come rapporto con una realtà intrapsichica del paziente. Tanto meno è utile, poi, alimentare un proprio fantasma interno di "controgenitore" positivo, cercando di compensare l'inadeguatezza vera o presunta del genitore reale. Questo rischierebbe di favorire nell'adolescente una scissione tra genitore vero cattivo/intollerante e genitore-terapeuta buono/ accogliente, con conseguenze spiacevoli sulla possibilità di definire un elemento intrapsichico di tipo evolutivo.
Consentire a che l'adolescente non riconosca apertamente i propri bisogni significa diventare complici di quella parte di lui che non vuole cambiare il proprio stato originario, significa non credere - noi per primi come terapeuti - alla sua possibilità di essere adulto, schiacciandolo lungo l'asse di partenza ed eliminando la dualità necessaria al movimento, sia pure conflittuale. Del resto, chi approda alla terapia porta già il sintomo o la sofferenza di una lotta fra parti interne divergenti. Il compito dell'analista non è però eliminare o sottacere la divergenza, ma ricondurre lo scontro a polarità coniugabili in un esito evolutivo. Si tratta cioè di trasformare il conflitto in un'evento costruttivo e non ostruttivo (Loriedo -1992), disvelando quali ne siano i termini reali ed elaborandone la soluzione attraverso una gamma di possibilità. Ma per poter pervenire a questo risultato insieme al paziente è necessario che il conflitto sia riconosciuto da entrambi. Diversamente, il rischio è di atteggiarsi come quei genitori che pretendono di essere gli "amici" dei propri figli, in un modo falsamente democratico e solidale che, ammortizzando gli urti e velando i contrasti, sottrae loro la possibilità dello scontro e della differenziazione. Del resto, l'eventuale scontro può essere utile a sciogliere la tensione relativa al conflitto interno del paziente.
Quando, invece, l'adolescente imposta il proprio rapporto con il terapeuta senza una chiara domanda di aiuto, intende di fatto proporre con lui un rapporto specifico (Carli 1988), in cui non sia consentito - nella definizione di un patto dichiarato - lo scioglimento della tensione comunque implicita nella richiesta di incontro.
Come qualcuno ha evidenziato (Wilson-1982), il non richiedere aiuto veicola una notevole seduttività, che consiste nel provocare e lasciar montare - con l'andare in seduta - una carica emotiva nel terapeuta, senza che però essa possa essere espressa e contenuta in un rapporto descrivibile. Viene alla mente la situazione che si costituisce in alcuni casi di incesto adombrato e non agito, quando il fenomeno non è facilmente riconoscibile perché non si è verificato niente e quindi è tanto più difficile reagire alla crescente tensione erotica. Come l'abusante in fondo è lė "senza fare nulla " e inchioda a questo nulla la sua vittima, anche questo tipo di adolescente è lė, non si sottrae apertamente alla terapia, ma disconosce la funzione terapeutica col mantenere celata la domanda che può attivarla in modo condiviso. Egli porta il suo esserci non come una reale presenza, ma come un sintomo, come un fattore di disagio che - per essere cosi ovviamente agito - diventa scontato e indiscutibile - (rischiando però di offuscare il livello di bisogno più profondo e la relativa richiesta). Ma si sa che c'è differenza tra rapporto erotizzato e rapporto erotico, il primo rivolto sostanzialmente solo ad un fantasma interno, il secondo basato su effettivi e reali rapporti sessuali e pertanto evolutivo, in quanto l'eros non è narcisisticamente ripiegato su se stesso, ma si arricchisce di un effettivo apporto dell'altro. Ma l'"altro" allora - l'analista, nel nostro caso - deve pur esserci! Deve potersi porre in modo sufficientemente definito, tale da rendersi presente e reale nel vissuto analitico del paziente. Accettare l'indefinizione della domanda adolescenziale come propria della condizione psico- cronologica corrispondente sembra un leggere la funzione analitica più come materno/accogliente che non come paterno/separante - nella fattispecie, da uno stadio evolutivo precedente. Il rapporto analitico è paragonabile, per certi versi, ad una situazione uroborica di fusionalità, nella quale il paziente può regredire per attingere l'eros necessario alla propria evoluzione. Ma la regressione non può impedire la chiarezza della domanda, altrimenti l'eros non può essere impegnato in senso evolutivo, rischiando continuamente di essere ribaltato indietro a dirimere una questione preliminare.
Inoltre, se è vero che il paziente ripropone nella relazione analitica il proprio modo abituale di reagire ai contenuti che non gli è riuscito di integrare, la modalità di lavoro più esplicita ha il pregio di mettere in discussione - nei fatti - la sua maniera patologica di fronteggiare l'ansia ricorrendo a modalità seduttive e di controllo che, non dichiarandolo, eludono il conflitto e lo rendono perciò sempre meno risolvibile. All'inizio della terapia Marina si descriveva sempre in forse sul partire o no per un viaggio all'estero. Più tardi, impostato il lavoro nel senso descritto, riuscirà ad ammettere che questo dire marginalmente senza definire mai era il modo da lei sempre adottato per sfuggire all'angoscia che le derivava dal controllo dei genitori. Ma era anche - disse - una dichiarazione di fallimento rispetto alla possibilità di porsi come soggetto autentico di una relazione più profonda con loro.
Addestrare al conflitto è stato - in questo caso - introdurre un paterno di tipo positivo. Se dunque l'Uroboro è una plausibile metafora della terapia, direi - con uno sguardo a Neumann (1980) - che debba piuttosto trattarsi di un uroboro patriarcale, che contenga già in sé un nucleo di saggezza istintuale, una spiritualità emanante dall'eros stesso e capace di dirigerlo. Questa immagine cosė intensa credo possa dissipare il timore di agire un logos di tipo genitoriale ed espulsivo, consentendo invece all'analista di soste nere fino in fondo il ruolo dell'Osservatore. Mi riferisco a quella parte che è dentro ognuno di noi e che riesce a distaccarsi dai bisogni nevrotici per suggerirci, pur senza la pretesa di obbligarci a nulla, la via migliore per l'individuazione. Questa parte - dice Hillman - "vede le cose cosi come sono veramente. Non deve (necessariamente) influenzarci, ma non intende cedere" (Hillman - 1992).
* Psicologo, Psicoterapeuta